[:it]
Le Sezio ni unite della Cassazione, con la sentenza 25 gennaio 2017 n. 1946, su richiesta formulata dal Procuratore generale ai sensi dell’art 363 comma 1 c.p.c., affrontano, per la prima volta, la questione dell’attuabilità della tutela giurisdizionale del diritto all’accesso alle origini da parte del figlio nato da madre che al momento del parto dichiarava di voler rimanere anonima.
ni unite della Cassazione, con la sentenza 25 gennaio 2017 n. 1946, su richiesta formulata dal Procuratore generale ai sensi dell’art 363 comma 1 c.p.c., affrontano, per la prima volta, la questione dell’attuabilità della tutela giurisdizionale del diritto all’accesso alle origini da parte del figlio nato da madre che al momento del parto dichiarava di voler rimanere anonima.
Afferma la sentenza che in tema di parto anonimo, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativa e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 278 del 2013, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.
Precedentemente:
– la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva condannato l’Italia ritenendo che il diritto all’anonimato della donna, così come era disciplinato dal comma 7 dell’art. 28 l. adoz., comportasse una violazione del diritto del figlio a conoscere le proprie origini: impedire ad una persona di sapere da chi è nato, senza che operi il giusto bilanciamento tra l’interesse della madre all’anonimato e quello del figlio alla conoscenza delle proprie origini, costituisce violazione dell’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (Corte eur. dir. uomo, 25 settembre 2012, n. 33783).
– la Corte costituzionale poi, con sentenza additiva, aveva modificato il comma 7 dell’art. 28, L. n. 184/1983, introducendo così la possibilità che, su richiesta del figlio, la madre, che al momento del parto avesse dichiarato di non voler essere nominata, potesse essere interpellata al fine di verificare se intendesse revocare la propria dichiarazione di anonimato. L’irreversibilità della scelta materna all’anonimato, infatti, è stata giudicata costituzionalmente illegittima, stante la necessità di coordinare il diritto all’anonimato materno da un lato e, dall’altro, il diritto a conoscere le proprie origini, quale espressione del diritto alla identità personale (Corte cost. 22 novembre 2013, n. 278).
In seguito della predetta pronuncia della Consulta, nel panorama giurisprudenziale si sono venuti a delineare due distinti orientamenti:
– secondo il primo orientamento, seguito anche dai Tribunali per i minorenni di Milano, di Catania, di Bologna e di Salerno, doveva attribuirsi alla sentenza n. 278 del 2013 natura di “pronuncia additiva di principio”, in quanto la Consulta con l’inciso “attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza” istituiva una riserva di legge nell’individuazione del procedimento d’interpello per non vanificare la garanzia di segretezza sul parto riconosciuta dall’ordinamento alla donna. Pertanto, l’interpello della madre non poteva avvenire con modalità direttamente individuate dal giudice risultando tale intervento indebito nonché invasivo degli altri poteri dello Stato;
– ad avviso del a secondo orientamente, seguito dai tribunali per i minorenni di Trieste, Piemonte, Valle d’Aosta e dalla Corte d’appello di Catania (Sezione famiglia, delle persone e dei minori), in forza dei principi enunciati dalla sentenza Cedu (Godelli c. Italia) e per effetto della sentenza sopracitata della Consulta, era possibile l’interpello riservato anche senza la legge. L’art 28 comma 7 della L. 184/1983, infatti, in quanto dichiarato incostituzionale non poteva essere più applicato.
In proposito va ricordato anche che l’art. 250 c.c. pone il principio dell’assoluta volontarietà del riconoscimento: l’anonimato della madre nubile deriva non tanto dalla dichiarazione di non voler essere nominata quanto dalla mancata creazione del rapporto di filiazione con il nato.
Invece, per la donna coniugata che abbia generato il figlio con persona diversa dal marito, dovrà avere riguardo all’art. 30 ord. st. civ. che, prevedendo al 1 comma la possibilità di dichiarare di non voler essere nominata, le consente di mantenere l’anonimato (in difetto l’indicazione della donna coniugata comporterebbe l’applicazione della presunzione di paternità del marito ex art. 231 c.c.).
Ambedue le disposizioni non contengono limiti di “durata”. Nulla osta quindi a che, in un momento successivo, la donna possa essere nuovamente chiamata a “scegliere” tra restare anonima o permettere la sua identificazione.
In assenza di un intervento legislativo volto a dettare la procedura atta all’interpello stesso la sentenza in esame afferma l’insussistenza di ostacoli, per il giudice, di “mutuare dall’ordinamento ….. un meccanismo utile a garantire la tutela dei diritti nascenti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale”.
Deve seguirsi il c.d. procedimento “base” di volontaria giurisdizione, in camera di consiglio, dinanzi al tribunale per i minorenni del luogo di residenza, così come previsto dai commi 5 e 6 art. 28, L. n. 184/1983. Cioè a dire il medesimo procedimento che trova applicazione per la ricerca delle origini del figlio adottato, può adattarsi al caso del figlio che richiede al giudice di autorizzare le ricerche e il successivo interpello della madre biologica circa la sua volontà di mantenere ancora ferma la dichiarazione di anonimato, ovvero di revocarla.
Nell’ambito di tale procedimento, inoltre, si deve rispettare quanto stabilito dall’art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali – là dove delineano modalità idonee a preservare la massima segretezza e riservatezza pur consentendo di comunicare tutte le informazioni relative alla cartella clinica, purché non identificative – nonché al comma 6 dell’art. 28 L. n. 184/1983: l’accesso per l’adottato alle notizie sulla sua origine e sulla identità dei genitori deve essere consentito con modalità che assicurino sia l’equilibrio psico-fisico del figlio che il massimo rispetto della madre e della sua libertà di autodeterminazione.
Si noti bene:
– i tribunali per i minorenni hanno già attivato prassi che consentono indagini sulla identificazione della madre, nonché l’accertamento della sua sussistenza in vita.
– In caso di riscontro positivo, la donna viene convocata per “comunicazioni orali” dal giudice, tenendo peraltro segreto il motivo della convocazione stessa, che verrà disvelato solo nel colloquio con il giudice, al quale peraltro saranno state date tutte le informazioni relative alle condizioni psico-fisiche della donna in modo che venga adottata ogni possibile cautela.
– In caso di diniego di consenso – ovvero là dove la madre esprima la propria volontà di mantenere l’anonimato – il giudice ne dà solo riferimento scritto senza formare alcun verbale e senza comunicare il nome del richiedente; se, al contrario, la donna acconsente, revocando la dichiarazione di non voler essere nominata, viene redatto il verbale, sottoscritto anche dalla madre, e viene comunicato il nome del figlio.
– Nell’ipotesi in cui, al contrario, la madre risulti deceduta, la stessa giurisprudenza ritiene che il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini non incontri più alcun limite, posto che, diversamente, verrebbe meno un suo diritto fondamentale, senza che sussistano più quelle ragioni di tutela e protezione, riconosciutele nel corso della vita e che solo lei può escludere con la revoca della propria dichiarazione di anonimato (Cass. civ. sez. I, 21 luglio 2016, n. 15024; Cass. civ. sez. I, 9 novembre 2016, n. 22838; App. Catania 13 gennaio 2016).
[:en]
Cass. S.U. 25 gennaio 2017 n. 1946 sul diritto a conoscere le proprie origini
le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 25 gennaio 2017 n. 1946, su richiesta formulata dal Procuratore generale ai sensi dell’art 363 comma 1 c.p.c., affrontano, per la prima volta, la questione dell’attuabilità della tutela giurisdizionale del diritto all’accesso alle origini da parte del figlio nato da madre che al momento del parto dichiarava di voler rimanere anonima.
Afferma la sentenza che in tema di parto anonimo, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativa e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 278 del 2013, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in séguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.
Precedentemente:
– la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva condannato l’Italia ritenendo che il diritto all’anonimato della donna, così come era disciplinato dal comma 7 dell’art. 28 l. adoz., comportasse una violazione del diritto del figlio a conoscere le proprie origini: impedire ad una persona di sapere da chi è nato, senza che operi il giusto bilanciamento tra l’interesse della madre all’anonimato e quello del figlio alla conoscenza delle proprie origini, costituisce violazione dell’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (Corte eur. dir. uomo, 25 settembre 2012, n. 33783).
– la Corte costituzionale poi, con sentenza additiva, aveva modificato il comma 7 dell’art. 28, L. n. 184/1983, introducendo così la possibilità che, su richiesta del figlio, la madre, che al momento del parto avesse dichiarato di non voler essere nominata, potesse essere interpellata al fine di verificare se intendesse revocare la propria dichiarazione di anonimato. L’irreversibilità della scelta materna all’anonimato, infatti, è stata giudicata costituzionalmente illegittima, stante la necessità di coordinare il diritto all’anonimato materno da un lato e, dall’altro, il diritto a conoscere le proprie origini, quale espressione del diritto alla identità personale (Corte cost. 22 novembre 2013, n. 278).
In seguito della predetta pronuncia della Consulta, nel panorama giurisprudenziale si sono venuti a delineare due distinti orientamenti:
– secondo il primo orientamento, seguito anche dai Tribunali per i minorenni di Milano, di Catania, di Bologna e di Salerno, doveva attribuirsi alla sentenza n. 278 del 2013 natura di “pronuncia additiva di principio”, in quanto la Consulta con l’inciso “attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza” istituiva una riserva di legge nell’individuazione del procedimento d’interpello per non vanificare la garanzia di segretezza sul parto riconosciuta dall’ordinamento alla donna. Pertanto, l’interpello della madre non poteva avvenire con modalità direttamente individuate dal giudice risultando tale intervento indebito nonché invasivo degli altri poteri dello Stato;
– ad avviso del a secondo orientamente, seguito dai tribunali per i minorenni di Trieste, Piemonte, Valle d’Aosta e dalla Corte d’appello di Catania (Sezione famiglia, delle persone e dei minori), in forza dei principi enunciati dalla sentenza Cedu (Godelli c. Italia) e per effetto della sentenza sopracitata della Consulta, era possibile l’interpello riservato anche senza la legge. L’art 28 comma 7 della L. 184/1983, infatti, in quanto dichiarato incostituzionale non poteva essere più applicato.
In proposito va ricordato anche che l’art. 250 c.c. pone il principio dell’assoluta volontarietà del riconoscimento: l’anonimato della madre nubile deriva non tanto dalla dichiarazione di non voler essere nominata quanto dalla mancata creazione del rapporto di filiazione con il nato.
Invece, per la donna coniugata che abbia generato il figlio con persona diversa dal marito, dovrà avere riguardo all’art. 30 ord. st. civ. che, prevedendo al 1 comma la possibilità di dichiarare di non voler essere nominata, le consente di mantenere l’anonimato (in difetto l’indicazione della donna coniugata comporterebbe l’applicazione della presunzione di paternità del marito ex art. 231 c.c.).
Ambedue le disposizioni non contengono limiti di “durata”. Nulla osta quindi a che, in un momento successivo, la donna possa essere nuovamente chiamata a “scegliere” tra restare anonima o permettere la sua identificazione.
In assenza di un intervento legislativo volto a dettare la procedura atta all’interpello stesso la sentenza in esame afferma l’insussistenza di ostacoli, per il giudice, di “mutuare dall’ordinamento ….. un meccanismo utile a garantire la tutela dei diritti nascenti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale”.
Deve seguirsi il c.d. procedimento “base” di volontaria giurisdizione, in camera di consiglio, dinanzi al tribunale per i minorenni del luogo di residenza, così come previsto dai commi 5 e 6 art. 28, L. n. 184/1983. Cioè a dire il medesimo procedimento che trova applicazione per la ricerca delle origini del figlio adottato, può adattarsi al caso del figlio che richiede al giudice di autorizzare le ricerche e il successivo interpello della madre biologica circa la sua volontà di mantenere ancora ferma la dichiarazione di anonimato, ovvero di revocarla.
Nell’ambito di tale procedimento, inoltre, si deve rispettare quanto stabilito dall’art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali – là dove delineano modalità idonee a preservare la massima segretezza e riservatezza pur consentendo di comunicare tutte le informazioni relative alla cartella clinica, purché non identificative – nonché al comma 6 dell’art. 28 L. n. 184/1983: l’accesso per l’adottato alle notizie sulla sua origine e sulla identità dei genitori deve essere consentito con modalità che assicurino sia l’equilibrio psico-fisico del figlio che il massimo rispetto della madre e della sua libertà di autodeterminazione.
Si noti bene:
– i tribunali per i minorenni hanno già attivato prassi che consentono indagini sulla identificazione della madre, nonché l’accertamento della sua sussistenza in vita.
– In caso di riscontro positivo, la donna viene convocata per “comunicazioni orali” dal giudice, tenendo peraltro segreto il motivo della convocazione stessa, che verrà disvelato solo nel colloquio con il giudice, al quale peraltro saranno state date tutte le informazioni relative alle condizioni psico-fisiche della donna in modo che venga adottata ogni possibile cautela.
– In caso di diniego di consenso – ovvero là dove la madre esprima la propria volontà di mantenere l’anonimato – il giudice ne dà solo riferimento scritto senza formare alcun verbale e senza comunicare il nome del richiedente; se, al contrario, la donna acconsente, revocando la dichiarazione di non voler essere nominata, viene redatto il verbale, sottoscritto anche dalla madre, e viene comunicato il nome del figlio.
– Nell’ipotesi in cui, al contrario, la madre risulti deceduta, la stessa giurisprudenza ritiene che il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini non incontri più alcun limite, posto che, diversamente, verrebbe meno un suo diritto fondamentale, senza che sussistano più quelle ragioni di tutela e protezione, riconosciutele nel corso della vita e che solo lei può escludere con la revoca della propria dichiarazione di anonimato (Cass. civ. sez. I, 21 luglio 2016, n. 15024; Cass. civ. sez. I, 9 novembre 2016, n. 22838; App. Catania 13 gennaio 2016).
[:fr]
Cass. S.U. 25 gennaio 2017 n. 1946 sul diritto a conoscere le proprie origini
le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 25 gennaio 2017 n. 1946, su richiesta formulata dal Procuratore generale ai sensi dell’art 363 comma 1 c.p.c., affrontano, per la prima volta, la questione dell’attuabilità della tutela giurisdizionale del diritto all’accesso alle origini da parte del figlio nato da madre che al momento del parto dichiarava di voler rimanere anonima.
Afferma la sentenza che in tema di parto anonimo, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativa e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 278 del 2013, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in séguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.
Precedentemente:
– la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva condannato l’Italia ritenendo che il diritto all’anonimato della donna, così come era disciplinato dal comma 7 dell’art. 28 l. adoz., comportasse una violazione del diritto del figlio a conoscere le proprie origini: impedire ad una persona di sapere da chi è nato, senza che operi il giusto bilanciamento tra l’interesse della madre all’anonimato e quello del figlio alla conoscenza delle proprie origini, costituisce violazione dell’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (Corte eur. dir. uomo, 25 settembre 2012, n. 33783).
– la Corte costituzionale poi, con sentenza additiva, aveva modificato il comma 7 dell’art. 28, L. n. 184/1983, introducendo così la possibilità che, su richiesta del figlio, la madre, che al momento del parto avesse dichiarato di non voler essere nominata, potesse essere interpellata al fine di verificare se intendesse revocare la propria dichiarazione di anonimato. L’irreversibilità della scelta materna all’anonimato, infatti, è stata giudicata costituzionalmente illegittima, stante la necessità di coordinare il diritto all’anonimato materno da un lato e, dall’altro, il diritto a conoscere le proprie origini, quale espressione del diritto alla identità personale (Corte cost. 22 novembre 2013, n. 278).
In seguito della predetta pronuncia della Consulta, nel panorama giurisprudenziale si sono venuti a delineare due distinti orientamenti:
– secondo il primo orientamento, seguito anche dai Tribunali per i minorenni di Milano, di Catania, di Bologna e di Salerno, doveva attribuirsi alla sentenza n. 278 del 2013 natura di “pronuncia additiva di principio”, in quanto la Consulta con l’inciso “attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza” istituiva una riserva di legge nell’individuazione del procedimento d’interpello per non vanificare la garanzia di segretezza sul parto riconosciuta dall’ordinamento alla donna. Pertanto, l’interpello della madre non poteva avvenire con modalità direttamente individuate dal giudice risultando tale intervento indebito nonché invasivo degli altri poteri dello Stato;
– ad avviso del a secondo orientamente, seguito dai tribunali per i minorenni di Trieste, Piemonte, Valle d’Aosta e dalla Corte d’appello di Catania (Sezione famiglia, delle persone e dei minori), in forza dei principi enunciati dalla sentenza Cedu (Godelli c. Italia) e per effetto della sentenza sopracitata della Consulta, era possibile l’interpello riservato anche senza la legge. L’art 28 comma 7 della L. 184/1983, infatti, in quanto dichiarato incostituzionale non poteva essere più applicato.
In proposito va ricordato anche che l’art. 250 c.c. pone il principio dell’assoluta volontarietà del riconoscimento: l’anonimato della madre nubile deriva non tanto dalla dichiarazione di non voler essere nominata quanto dalla mancata creazione del rapporto di filiazione con il nato.
Invece, per la donna coniugata che abbia generato il figlio con persona diversa dal marito, dovrà avere riguardo all’art. 30 ord. st. civ. che, prevedendo al 1 comma la possibilità di dichiarare di non voler essere nominata, le consente di mantenere l’anonimato (in difetto l’indicazione della donna coniugata comporterebbe l’applicazione della presunzione di paternità del marito ex art. 231 c.c.).
Ambedue le disposizioni non contengono limiti di “durata”. Nulla osta quindi a che, in un momento successivo, la donna possa essere nuovamente chiamata a “scegliere” tra restare anonima o permettere la sua identificazione.
In assenza di un intervento legislativo volto a dettare la procedura atta all’interpello stesso la sentenza in esame afferma l’insussistenza di ostacoli, per il giudice, di “mutuare dall’ordinamento ….. un meccanismo utile a garantire la tutela dei diritti nascenti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale”.
Deve seguirsi il c.d. procedimento “base” di volontaria giurisdizione, in camera di consiglio, dinanzi al tribunale per i minorenni del luogo di residenza, così come previsto dai commi 5 e 6 art. 28, L. n. 184/1983. Cioè a dire il medesimo procedimento che trova applicazione per la ricerca delle origini del figlio adottato, può adattarsi al caso del figlio che richiede al giudice di autorizzare le ricerche e il successivo interpello della madre biologica circa la sua volontà di mantenere ancora ferma la dichiarazione di anonimato, ovvero di revocarla.
Nell’ambito di tale procedimento, inoltre, si deve rispettare quanto stabilito dall’art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali – là dove delineano modalità idonee a preservare la massima segretezza e riservatezza pur consentendo di comunicare tutte le informazioni relative alla cartella clinica, purché non identificative – nonché al comma 6 dell’art. 28 L. n. 184/1983: l’accesso per l’adottato alle notizie sulla sua origine e sulla identità dei genitori deve essere consentito con modalità che assicurino sia l’equilibrio psico-fisico del figlio che il massimo rispetto della madre e della sua libertà di autodeterminazione.
Si noti bene:
– i tribunali per i minorenni hanno già attivato prassi che consentono indagini sulla identificazione della madre, nonché l’accertamento della sua sussistenza in vita.
– In caso di riscontro positivo, la donna viene convocata per “comunicazioni orali” dal giudice, tenendo peraltro segreto il motivo della convocazione stessa, che verrà disvelato solo nel colloquio con il giudice, al quale peraltro saranno state date tutte le informazioni relative alle condizioni psico-fisiche della donna in modo che venga adottata ogni possibile cautela.
– In caso di diniego di consenso – ovvero là dove la madre esprima la propria volontà di mantenere l’anonimato – il giudice ne dà solo riferimento scritto senza formare alcun verbale e senza comunicare il nome del richiedente; se, al contrario, la donna acconsente, revocando la dichiarazione di non voler essere nominata, viene redatto il verbale, sottoscritto anche dalla madre, e viene comunicato il nome del figlio.
– Nell’ipotesi in cui, al contrario, la madre risulti deceduta, la stessa giurisprudenza ritiene che il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini non incontri più alcun limite, posto che, diversamente, verrebbe meno un suo diritto fondamentale, senza che sussistano più quelle ragioni di tutela e protezione, riconosciutele nel corso della vita e che solo lei può escludere con la revoca della propria dichiarazione di anonimato (Cass. civ. sez. I, 21 luglio 2016, n. 15024; Cass. civ. sez. I, 9 novembre 2016, n. 22838; App. Catania 13 gennaio 2016).
[:es]
Cass. S.U. 25 gennaio 2017 n. 1946 sul diritto a conoscere le proprie origini
le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 25 gennaio 2017 n. 1946, su richiesta formulata dal Procuratore generale ai sensi dell’art 363 comma 1 c.p.c., affrontano, per la prima volta, la questione dell’attuabilità della tutela giurisdizionale del diritto all’accesso alle origini da parte del figlio nato da madre che al momento del parto dichiarava di voler rimanere anonima.
Afferma la sentenza che in tema di parto anonimo, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativa e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 278 del 2013, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in séguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.
Precedentemente:
– la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva condannato l’Italia ritenendo che il diritto all’anonimato della donna, così come era disciplinato dal comma 7 dell’art. 28 l. adoz., comportasse una violazione del diritto del figlio a conoscere le proprie origini: impedire ad una persona di sapere da chi è nato, senza che operi il giusto bilanciamento tra l’interesse della madre all’anonimato e quello del figlio alla conoscenza delle proprie origini, costituisce violazione dell’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (Corte eur. dir. uomo, 25 settembre 2012, n. 33783).
– la Corte costituzionale poi, con sentenza additiva, aveva modificato il comma 7 dell’art. 28, L. n. 184/1983, introducendo così la possibilità che, su richiesta del figlio, la madre, che al momento del parto avesse dichiarato di non voler essere nominata, potesse essere interpellata al fine di verificare se intendesse revocare la propria dichiarazione di anonimato. L’irreversibilità della scelta materna all’anonimato, infatti, è stata giudicata costituzionalmente illegittima, stante la necessità di coordinare il diritto all’anonimato materno da un lato e, dall’altro, il diritto a conoscere le proprie origini, quale espressione del diritto alla identità personale (Corte cost. 22 novembre 2013, n. 278).
In seguito della predetta pronuncia della Consulta, nel panorama giurisprudenziale si sono venuti a delineare due distinti orientamenti:
– secondo il primo orientamento, seguito anche dai Tribunali per i minorenni di Milano, di Catania, di Bologna e di Salerno, doveva attribuirsi alla sentenza n. 278 del 2013 natura di “pronuncia additiva di principio”, in quanto la Consulta con l’inciso “attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza” istituiva una riserva di legge nell’individuazione del procedimento d’interpello per non vanificare la garanzia di segretezza sul parto riconosciuta dall’ordinamento alla donna. Pertanto, l’interpello della madre non poteva avvenire con modalità direttamente individuate dal giudice risultando tale intervento indebito nonché invasivo degli altri poteri dello Stato;
– ad avviso del a secondo orientamente, seguito dai tribunali per i minorenni di Trieste, Piemonte, Valle d’Aosta e dalla Corte d’appello di Catania (Sezione famiglia, delle persone e dei minori), in forza dei principi enunciati dalla sentenza Cedu (Godelli c. Italia) e per effetto della sentenza sopracitata della Consulta, era possibile l’interpello riservato anche senza la legge. L’art 28 comma 7 della L. 184/1983, infatti, in quanto dichiarato incostituzionale non poteva essere più applicato.
In proposito va ricordato anche che l’art. 250 c.c. pone il principio dell’assoluta volontarietà del riconoscimento: l’anonimato della madre nubile deriva non tanto dalla dichiarazione di non voler essere nominata quanto dalla mancata creazione del rapporto di filiazione con il nato.
Invece, per la donna coniugata che abbia generato il figlio con persona diversa dal marito, dovrà avere riguardo all’art. 30 ord. st. civ. che, prevedendo al 1 comma la possibilità di dichiarare di non voler essere nominata, le consente di mantenere l’anonimato (in difetto l’indicazione della donna coniugata comporterebbe l’applicazione della presunzione di paternità del marito ex art. 231 c.c.).
Ambedue le disposizioni non contengono limiti di “durata”. Nulla osta quindi a che, in un momento successivo, la donna possa essere nuovamente chiamata a “scegliere” tra restare anonima o permettere la sua identificazione.
In assenza di un intervento legislativo volto a dettare la procedura atta all’interpello stesso la sentenza in esame afferma l’insussistenza di ostacoli, per il giudice, di “mutuare dall’ordinamento ….. un meccanismo utile a garantire la tutela dei diritti nascenti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale”.
Deve seguirsi il c.d. procedimento “base” di volontaria giurisdizione, in camera di consiglio, dinanzi al tribunale per i minorenni del luogo di residenza, così come previsto dai commi 5 e 6 art. 28, L. n. 184/1983. Cioè a dire il medesimo procedimento che trova applicazione per la ricerca delle origini del figlio adottato, può adattarsi al caso del figlio che richiede al giudice di autorizzare le ricerche e il successivo interpello della madre biologica circa la sua volontà di mantenere ancora ferma la dichiarazione di anonimato, ovvero di revocarla.
Nell’ambito di tale procedimento, inoltre, si deve rispettare quanto stabilito dall’art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali – là dove delineano modalità idonee a preservare la massima segretezza e riservatezza pur consentendo di comunicare tutte le informazioni relative alla cartella clinica, purché non identificative – nonché al comma 6 dell’art. 28 L. n. 184/1983: l’accesso per l’adottato alle notizie sulla sua origine e sulla identità dei genitori deve essere consentito con modalità che assicurino sia l’equilibrio psico-fisico del figlio che il massimo rispetto della madre e della sua libertà di autodeterminazione.
Si noti bene:
– i tribunali per i minorenni hanno già attivato prassi che consentono indagini sulla identificazione della madre, nonché l’accertamento della sua sussistenza in vita.
– In caso di riscontro positivo, la donna viene convocata per “comunicazioni orali” dal giudice, tenendo peraltro segreto il motivo della convocazione stessa, che verrà disvelato solo nel colloquio con il giudice, al quale peraltro saranno state date tutte le informazioni relative alle condizioni psico-fisiche della donna in modo che venga adottata ogni possibile cautela.
– In caso di diniego di consenso – ovvero là dove la madre esprima la propria volontà di mantenere l’anonimato – il giudice ne dà solo riferimento scritto senza formare alcun verbale e senza comunicare il nome del richiedente; se, al contrario, la donna acconsente, revocando la dichiarazione di non voler essere nominata, viene redatto il verbale, sottoscritto anche dalla madre, e viene comunicato il nome del figlio.
– Nell’ipotesi in cui, al contrario, la madre risulti deceduta, la stessa giurisprudenza ritiene che il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini non incontri più alcun limite, posto che, diversamente, verrebbe meno un suo diritto fondamentale, senza che sussistano più quelle ragioni di tutela e protezione, riconosciutele nel corso della vita e che solo lei può escludere con la revoca della propria dichiarazione di anonimato (Cass. civ. sez. I, 21 luglio 2016, n. 15024; Cass. civ. sez. I, 9 novembre 2016, n. 22838; App. Catania 13 gennaio 2016).
[:]


 A distanza di pochi mesi dal deposito della s
A distanza di pochi mesi dal deposito della s A molti sarà capitato di pubblicare contenuti sulla propria pagina Facebook, che vengono “segnalati” ingiustamente. Ad alcuni sarà anche capitato di veder sospeso o cancellato il proprio profilo, senza avere modo di giustificarsi al fine di evitare l’ingiusta sanzione.
A molti sarà capitato di pubblicare contenuti sulla propria pagina Facebook, che vengono “segnalati” ingiustamente. Ad alcuni sarà anche capitato di veder sospeso o cancellato il proprio profilo, senza avere modo di giustificarsi al fine di evitare l’ingiusta sanzione.

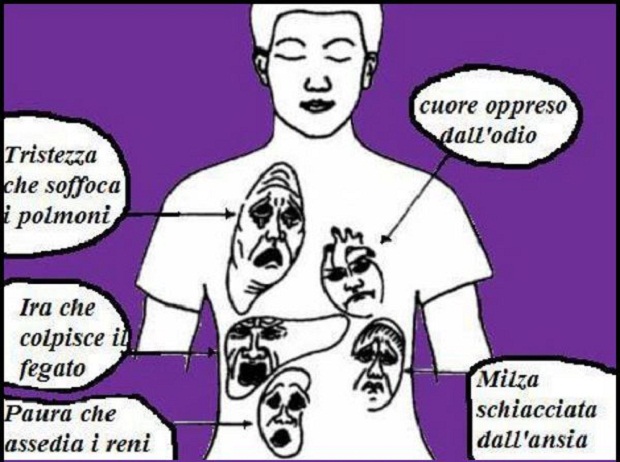 L’alterazione della vita o danno esistenziale che dir si voglia (e cioè il cosiddetto “danno esistenziale”) è una categoria di danno che non può essere liquidata sulla base di cifre ridicole e non ancorate a criteri oggettivi che prendano in seria considerazione gli effettivi pregiudizi subìti. In tal senso si è pronunciata la sentenza n. 12470 del 18 maggio 2017, della Corte di Cassazione civile che nel riconoscere il danno da “alterazione del rapporto familiare” – quale quello sofferto dalla moglie dell’infortunato gravemente invalido che vede compromessa la vita familiare, sessuale e sociale – ha affermato che lo stesso dev’essere risarcito secondo i criteri delle tabelle di Milano e più non sulla mera applicazione di un criterio equitativo puro.
L’alterazione della vita o danno esistenziale che dir si voglia (e cioè il cosiddetto “danno esistenziale”) è una categoria di danno che non può essere liquidata sulla base di cifre ridicole e non ancorate a criteri oggettivi che prendano in seria considerazione gli effettivi pregiudizi subìti. In tal senso si è pronunciata la sentenza n. 12470 del 18 maggio 2017, della Corte di Cassazione civile che nel riconoscere il danno da “alterazione del rapporto familiare” – quale quello sofferto dalla moglie dell’infortunato gravemente invalido che vede compromessa la vita familiare, sessuale e sociale – ha affermato che lo stesso dev’essere risarcito secondo i criteri delle tabelle di Milano e più non sulla mera applicazione di un criterio equitativo puro.

 ni unite della Cassazione, con la sentenza 25 gennaio 2017 n. 1946, su richiesta formulata dal Procuratore generale ai sensi dell’art 363 comma 1 c.p.c., affrontano, per la prima volta, la questione dell’attuabilità della tutela giurisdizionale del diritto all’accesso alle origini da parte del figlio nato da madre che al momento del parto dichiarava di voler rimanere anonima.
ni unite della Cassazione, con la sentenza 25 gennaio 2017 n. 1946, su richiesta formulata dal Procuratore generale ai sensi dell’art 363 comma 1 c.p.c., affrontano, per la prima volta, la questione dell’attuabilità della tutela giurisdizionale del diritto all’accesso alle origini da parte del figlio nato da madre che al momento del parto dichiarava di voler rimanere anonima. La legge non prevede limiti di età per chi intende generare un figlio.
La legge non prevede limiti di età per chi intende generare un figlio.