[:it]
Unioni civili e convivenze di fatto – legge 20 maggio 2016 n. 76
In data 5 giugno 2016 entrerà in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) riguardante la: “ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
Nei successivi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge saranno stabilite, con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’Interno, le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile nelle more dell’entrata in vigore dei decreti legislativi che, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge, dovranno essere adottati dal Governo al fine di adeguare i testi di legge vigenti al nuovo istituto.
La legge è formata da un unico articolo, composto a sua volta da 69 commi così suddivisi:
- dal comma 1° al comma 35° sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso:
- dal comma 36° al comma 65° sono regolamentate le convivenze di fatto, riguardanti indistintamente coppie omosessuali che eterosessuali .
LE UNIONI CIVILI
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile, resa alla presenza di due testimoni.
L’ufficiale di stato civile provvede successivamente alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui, a seguito a una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
Non è possibile costituire unioni civile nel caso in cui sussista:
- per una delle parti, un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
- l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
- tra le parti legate dai rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale , il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale dello stato civile
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
- Residenza e indirizzo della vita familiare
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
Il comma 21 estende parzialmente la disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.
In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile che sia prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).
- Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie per morte di una delle parti. All’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.
- Chi ha contratto matrimonio all’estero
Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all’estero è prevista l’applicazione della disciplina dell’unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato . Occorrerà a riguardo attendere l’emanazione dei decreti legislativi emessi dal Governo.
LE CONVIVENZE DI FATTO
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni: – unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile; – coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Le istruzioni ministeriali chiariranno con quale modalità i soggetti interessati dovranno formalizzare presso l’ufficio anagrafe l’intenzione di costituire una convivenza di fatto
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, in ogni caso per un periodo non superiore ai cinque anni.
Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
- Diritti all’assegnazione della casa popolare
Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
- Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
E’ esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.
In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile al convivente superstite si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
- Il contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Copia dell’accordo sarà trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi con modalità che saranno indicate nelle istruzioni ministeriali successive.
Il contratto può contenere:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza.
- Nullità del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:
- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
- in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
- minore età di uno dei conviventi;
- interdizione di una delle parti;
- condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte;
- Risoluzione del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza si risolve per:
- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei contraenti.
La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’ atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora esso versi in stato di bisogno o non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438 secondo comma del c.c. (in proporzione ai bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Gli stessi non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale).
Il giudice può obbligare l’ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall’art. 433 cc. non siano in grado di farlo.
In base all’articolo citato i conviventi si situano al penultimo posto, prima dei fratelli.[:]
 La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n°19345/16, è ritornata sull’annosa questione relativa alla debenza dell’assegno divorzile in caso di creazione da parte del beneficiario di una nuova famiglia.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n°19345/16, è ritornata sull’annosa questione relativa alla debenza dell’assegno divorzile in caso di creazione da parte del beneficiario di una nuova famiglia.
 Un uomo agisce davanti all’autorità giudiziaria italiana competente – la Corte d’appello – per il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica anche per la legge dello Stato.
Un uomo agisce davanti all’autorità giudiziaria italiana competente – la Corte d’appello – per il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica anche per la legge dello Stato. L’infedeltà – così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione – viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143, secondo comma, cod. civ.) così da infirmare, alla radice, l’affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione. È quindi la premessa, secondo l’id quod plerumque accidit, dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi (art. 151, primo comma, cod. civ.).
L’infedeltà – così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione – viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143, secondo comma, cod. civ.) così da infirmare, alla radice, l’affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione. È quindi la premessa, secondo l’id quod plerumque accidit, dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi (art. 151, primo comma, cod. civ.). Un lavoratore, dipendente di banca, viene collocato in una postazione tale da essere isolato rispetto ai colleghi, con conseguente aggravamento della sua già precaria condizione psichica.
Un lavoratore, dipendente di banca, viene collocato in una postazione tale da essere isolato rispetto ai colleghi, con conseguente aggravamento della sua già precaria condizione psichica.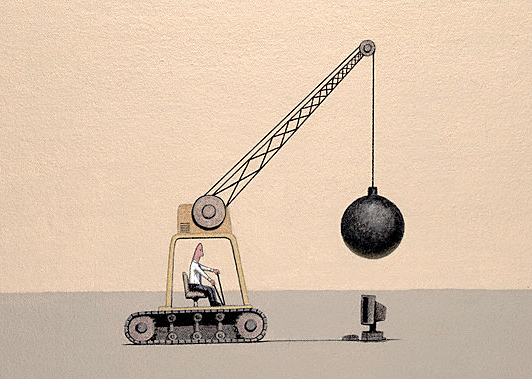 Ove uno dei coniugi acquisti in regime di comunione o effettui la costruzione di un edificio su suolo comune ad entrambi, tanto il primo cespite quanto il secondo, diventano, pro quota, di proprietà di entrambi i coniugi.
Ove uno dei coniugi acquisti in regime di comunione o effettui la costruzione di un edificio su suolo comune ad entrambi, tanto il primo cespite quanto il secondo, diventano, pro quota, di proprietà di entrambi i coniugi. La III^ Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2506 del 9 febbraio 2016 è tornata a trattare il tema del comodato sorto per esigenze familiari. Riprendendo quanto già affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella pronuncia 20448/2014, è stato sostenuto come debba essere compiuta, con riferimento alla fattispecie concreta, in primo luogo una distinzione in ragione al tipo di comodato stipulato tra le parti. Difatti, qualora si tratti di un comodato destinato a soddisfare le esigenze di cui si è detto, esso dovrà protrarsi fino al perdurare di dette esigenze familiari, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1809 c.c. In tale ipotesi non è ammissibile, da parte del comodante, far valere il proprio diritto di recesso, fatta salva l’eventualità dell’estinzione dei bisogni de quo. Al contrario, quando si versa nell’ipotesi di comodato sorto senza l’apposizione di un termine, neppure implicito, ovvero senza l’esplicita destinazione del bene a casa familiare, la disciplina applicabile sarà quella indicata dall’art. 1810 c.c., il quale consente il c.d. recesso ad nutum del comodante.
La III^ Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2506 del 9 febbraio 2016 è tornata a trattare il tema del comodato sorto per esigenze familiari. Riprendendo quanto già affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella pronuncia 20448/2014, è stato sostenuto come debba essere compiuta, con riferimento alla fattispecie concreta, in primo luogo una distinzione in ragione al tipo di comodato stipulato tra le parti. Difatti, qualora si tratti di un comodato destinato a soddisfare le esigenze di cui si è detto, esso dovrà protrarsi fino al perdurare di dette esigenze familiari, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1809 c.c. In tale ipotesi non è ammissibile, da parte del comodante, far valere il proprio diritto di recesso, fatta salva l’eventualità dell’estinzione dei bisogni de quo. Al contrario, quando si versa nell’ipotesi di comodato sorto senza l’apposizione di un termine, neppure implicito, ovvero senza l’esplicita destinazione del bene a casa familiare, la disciplina applicabile sarà quella indicata dall’art. 1810 c.c., il quale consente il c.d. recesso ad nutum del comodante. L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione ad un coniuge in ordine alla registrazione del trasferimento della proprietà di un immobile avvenuto a seguito degli accordi di separazione con la moglie. Il coniuge che aveva effettuato il trasferimento proponeva, allora, ricorso contro l’avviso di accertamento. L’Agenzia fiscale, costituendosi in giudizio, sosteneva che il trattamento agevolato era usufruibile solo per gli atti posti in essere in attuazione degli obblighi relativi all’affidamento dei figli, al loro mantenimento ed a quello del coniuge.
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione ad un coniuge in ordine alla registrazione del trasferimento della proprietà di un immobile avvenuto a seguito degli accordi di separazione con la moglie. Il coniuge che aveva effettuato il trasferimento proponeva, allora, ricorso contro l’avviso di accertamento. L’Agenzia fiscale, costituendosi in giudizio, sosteneva che il trattamento agevolato era usufruibile solo per gli atti posti in essere in attuazione degli obblighi relativi all’affidamento dei figli, al loro mantenimento ed a quello del coniuge. È sempre causa di scontro tra i genitori l’annosa questione del rimborso delle spese straordinarie sostenute dal genitore, affidatario o collocatario che sia, per i bisogni e le necessità dei figli.
È sempre causa di scontro tra i genitori l’annosa questione del rimborso delle spese straordinarie sostenute dal genitore, affidatario o collocatario che sia, per i bisogni e le necessità dei figli.